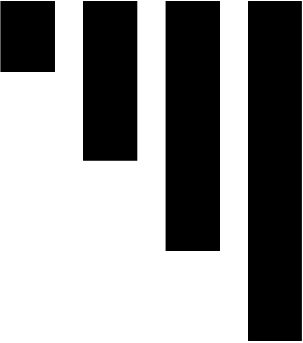Tiro fuori la mano dalle coperte per prendere il telefono, l’aria della camera è gelida. Accendo la lampada vicino al letto: zaino e scarpe se ne stanno lì a fissarmi. I vestiti invece li ho tenuti sotto le coperte, per trovarli caldi la mattina. Faccio di tutto per vestirmi senza uscire dalle coperte, raggiungendo gli angoli letto ancora freddi. Scendo le scale, la stufa tira ancora, sgranocchio qualcosa, mi allaccio le scarpe. Fuori è più caldo che dentro. La contrada è deserta, illuminata soltanto dalla mia frontale.

Sono le 05:30, è ancora buio, mancano due giorni alla fine dell’anno. Le foglie scricchiolano sotto i bastoncini, ma su a Forte Rione fa caldo. Quando arrivo a Contra’ Rossi inizia ad albeggiare: supero i ruderi, i fienili dismessi, le stalle in rovina. A una fontana, riempio la borraccia mentre un signore esce a fumare la prima sigaretta della giornata, mi guarda, non mi saluta. Tiro dritto. Cinquanta chilometri dopo sono di nuovo a casa. Un mio vicino, della contrada, mi offre una birra nella sua taverna, è fredda e vuota. Lui non abita più qui, come tutti d’altronde. Certo, c’è nato, ma a vent’anni è sceso in pianura «per andare operaio». Adesso torna su il fine settimana, a curare i fagioli, che qua vien buoni, o per bruscàre il ciliegio dietro la strada. Poi torna a casa, a Magrè, in pianura, come me.

La storia delle Alpi è una storia di migrazioni: una migrazione verso il basso, dei valligiani che scendevano in pianura per lavorare in fabbrica, come il mio vicino di casa; e una inversa, verso l’alto, dei cittadini alla ricerca di ciò che la città non era più in grado di offrire. Viazzo lo ha chiamato “paradosso alpino”. Tuttavia, in questa valle, questo movimento si è compiuto solo a metà: la gente se ne è andata, in valle sono rimasti i vecchi, e, una volta scomparsi anche loro, la valle si è svuotata definitivamente.

Col tempo ho imparato a prendere la corsa per quello che è, con leggerezza, senza patemi, e senza darle troppi significati; ma non ho smesso di pensare a ciò che mi mette davanti. Oggi ho corso cinquanta chilometri di cui non resterà nulla; non una traccia nel bosco, non nelle contrade. In effetti correre è un’attività piuttosto ecologica, come quasi tutte d’altronde, se ci si impegna un po’. E io me ne andrò come sono arrivato. Ma del resto, non rimarrà molto nemmeno del passaggio del mio vicino di casa, se non un orto ben curato – che è poca cosa di fronte a questi boschi. Qualcuno dice che siamo come fantasmi. Ed è quello che continuiamo a ripeterci di voler essere. Il problema è questa assenza, il nostro passare senza fermarci, e il nostro andarcene invece resteranno. Perché se antropizzare un luogo è disastroso, abbandonarlo dopo averlo fatto è ancora più irreparabile. Perché l’abbandono trascina con sé il degrado che secoli di civiltà rurali hanno evitato. Ci battiamo contro il cemento, ma a Valli, ora, è il bosco ad avanzare e mangiare i prati dove i caprioli, i galli e i radicchi vanno in amore. Non c’è più nessuno che falci il fieno. È vero, la nostra presenza sulle montagne ha delle conseguenze, ma la nostra assenza ancora di più.
Valli del Pasubio è un posto di cui le persone si sono dimenticate; se non quando, in estate, si fermano per comprare il panino con la soppressa prima di salire in Pasubio. Il problema di questo posto, a differenza che altrove, è che l’outdoor è talmente leggero da sorvolarlo. Correndo, scalando, sciando, il nostro sguardo punta sempre in alto – anche quando scendiamo. Ma di tanto in tanto, finché, sole in faccia, saliamo fissando la vetta, abituiamoci a far scivolare l’occhio indietro, verso la valle, pensando che anche quella, un tempo, è stata mondo.